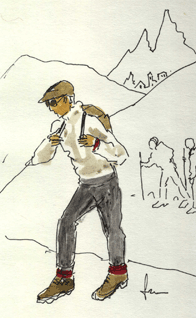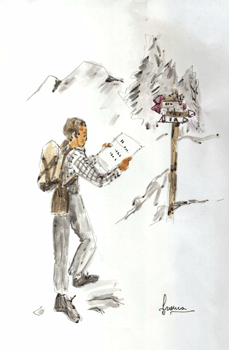|
| |
(ottobre 2016)
a cura di Nicola G.
De Toma, Vincenzo F. Scala, Vinicio Ruggiero
A - B
- C - D
- E - F
- G - H
- I - L
- M - N
- O - P
- Q - R
- S - T
- U - V
- W - Z
|
C
Cambiamento
"Cambia prima di essere costretto a farlo". Jack Welck (ex CEO General Electric)
"Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo". (Mahatma Gandhi)
Il Cambiamento appare come un paradigma positivo in tutti i campi. Cambiare significa:
- crescere in un significato nuovo di esistenza
- migliorare la propria personalità
- uscire dai circoli viziosi e dalle stanze chiuse
- stare meglio con sé stessi e nella propria esistenza
Cambiare significa spostare il proprio asse di equilibrio verso una posizione diversa, possibilmente migliore, più comoda, in modo che si possa andare incontro ad una situazione di vita diversa, più accettabile, migliore. Per fare questo bisogna imparare a sostituire qualcosa dentro di me, bisogna imparare ad accettare quello che gli altri o la società possono darmi, devo trasformare quello che mi viene dato in qualcosa di più fisiologico relativamente a me, e devo imparare a scambiare anche le mie cose, a donarle agli altri, a saperle donare. Devo imparare anche ad affrontare esperienze di vita nuove e a prendere da esse ciò che io riconosco come buono, che mi fa crescere. Così sarò diverso, avrò conosciuto il potere dello scambio e della sostituzione di parti di me, avrò imparato che non esiste una sola possibilità di vita, e sarò anche più forte, cresciuto, più responsabile di me stesso e degli altri.
La Montagna offre tutta una serie di possibilità di cambiamenti, attraverso una serie di risorse e dimensioni trasformative, che sono assolutamente importanti ai fini della pratica riabilitativa psicosociale:
- Il confronto cognitivo ed emozionale con spazi diversi (e non civilizzati) da quelli di cui si ha normalmente esperienza diretta e quotidiana: gli spazi aperti e l’ambiente esterno (il confronto con “l’altro” da me); il silenzio e la solitudine (il confronto con il “mio ambiente interiore”).
- La necessità di dotarsi di strumenti e competenze adeguate (l’orientamento, la capacità di “muoversi” su terreni impervi e su “percorsi” diversi, il sapersi “proteggere” dalle intemperie, il trovare un “equilibrio” utile, ecc.).
- La capacità, quindi, e la necessità di diventare autonomo.
- Il sostegno del gruppo e la fiducia nei compagni e nella guida.
- La condivisione dell’esperienza.
- L’ avere una “guida” ed il rapporto con essa.
- Il cambiamento della propria prospettiva di vista attraverso una dimensione di spostamento verticale e l’ “innalzarsi” (l’ascesa), come metafore di evoluzione personale.
- La dimensione esplorativa: l’incontro con il nuovo e lo sconosciuto.
- Le dimensioni temporale e progettuale del viaggio, e la possibilità del ricordo e della rielaborazione successiva (anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi: il prima, il durante, il dopo).
- La globalità dell’esperienza, che interessa la globalità fisica, sensoriale ed emotiva.
Camminare
Andare, procedere a piedi, spostandosi da un punto all’altro.
Il ripetersi di un passo dopo l’altro è come recitare
un mantra.
Camminare aiuta a rilassare la mente, a lasciar scivolare i pensieri
senza trattenerli, a far entrare nuovi pensieri e nuove idee,
ad essere creativi.
Cambiare ambiente familiare e sociale significa sentirsi liberi
da condizionamenti di carattere psicologico ed essere padroni
di scelte consapevoli.
Camminare, ammirare la natura, gli animali, socializzare con
le persone che si incontrano, parlare, cantare, ballare, sono
le cose semplici e normali a cui dovrà tendere l'uomo per
riscoprire una dimensione più umana e vitale, in armonia
con i ritmi della natura (Elio Sabena, Vivere il paesaggio). |
|
Bisogna riappropriarsi di ritmi più lenti, più umani,
e di comportamenti più naturali, perché questi sono
alla base di un buon equilibrio per ogni essere umano.
Camminare è un'attività piacevole, naturale,
sana, che consente un contatto diretto con l'ambiente che ci circonda.
E' senz'altro il modo ideale per godere della montagna.
E' difficile spiegare a parole quanto sia bello camminare, bisogna
sperimentarlo. Posso solo dire che è un'attività
praticabile da tutti, in qualunque stagione, a qualunque età,
che non richiede costose attrezzature, che non inquina e non fa
rumore. E' un'azione lenta, che permette di osservare anche le
piccole cose; silenziosa, che non disturba il pensiero e aiuta
a meditare; faticosa ma non estenuante, consente di sentire il
proprio corpo e di apprezzare le distanze guadagnate un passo
alla volta; autonoma, non si deve fare ricorso a mezzi meccanici,
si parte e ci si ferma quando lo si desidera, si procede al proprio
ritmo. Si può camminare da soli o in compagnia, in silenzio,
chiacchierando, fischiettando o, se uno ha fiato, anche cantando.
Si può andare praticamente ovunque e questo contribuisce
a dare un senso di grande libertà. E' gratis e permette
di godere dello spettacolo sempre nuovo della natura. Si può
fare una passeggiata di mezz'ora, di più ore o anche di
più giorni come i Tour del Monte Bianco e del Monte Rosa,
le Alte Vie della Valle d'Aosta o le numerose Grandes Randonnées
francesi. Negli ultimi anni stanno acquistando un crescente successo
gli antichi percorsi dei pellegrini, come il famoso cammino di
Santiago di Compostela o la riscoperta Via Francigena.
Camminare è un’attività salubre particolarmente
benefica per l'apparato muscolo-scheletrico, il sistema cardio-circolatorio
e l'apparato respiratorio. Se praticato con un po' di continuità,
riduce l'eccesso di grasso e aiuta a prevenire il diabete.
Risveglia tutti i nostri sensi, allontana lo stress, migliora
la condizione psico-fisica generale (da: www.naturaosta.it/camminare.htm
)
Campo Base
Il campo base è di solito il posto più comodo per
fare da base alla spedizione alpinistica, dove si trova acqua
e riparo da pericoli oggettivi e dove ci si può arrivare
abbastanza comodamente, senza dover scalare o inerpicarsi per
scivoli ghiacciati.
Dal campo base si parte per attrezzare i campi avanzati, che sono
disposti vicino alla parete o addirittura lungo la via di salita.
Il campo base è costituito da una tenda mensa, con tenda
attrezzata con cucina annessa e dalle singole tende dei partecipanti
alla spedizione.
Da qui partono i collegamenti via radio con la cordata che sta
salendo la via o attrezzando i vari campi.
Ovvio che a seconda della disponibilità economica della
spedizione, il campo base ha diverse dimensioni ed attrezzature.
Si passa dalla misura minima (tipica delle spedizione senza sponsor),
dove il campo è costituito da una singola tenda dove si
cucina, mangia e dove dormono cuoco e aiuto-cuoco (in genere si
usa una persona per cucinare, spesso coadiuvata da un giovane,
questi restano sempre al campo e sorvegliano che i locali non
spazzolino via tutto durante l' assenza degli alpinisti) e dalla
tendina che degli alpinisti (che avranno altre tende per i campi
successivi), alle mega organizzazioni dove diventa un vero piccolo
villaggio (tende attrezzatissine, con gruppi elettrogeni e corrente
elettrica, collegamenti satellitari, bagni chimici ...).
Quando si fa una spedizione in terre remote, ad esempio in himalaya,
si giunge dopo diversi giorni di marcia alla base della montagna.
Qui si allestisce il campo base, che dev'essere più confortevole
possibile, e dove si tengono a magazzino tutte le attrezzature
della spedizione.
a seconda della spedizione, il campo base rimane allestito per
un periodo di tempo più o meno lungo. per le spedizioni
più lunghe rimane allestito anche diverse settimane.
i campi intermedi sono i luoghi che gli alpinisti allestiscono
come punti di appoggio per pernottamento e/o altro quando l'ascensione
alla vetta richiede più di un giorno dal campo base.
i campi intermedi sono più leggeri, perché disposti
già lungo il tratto alpinistico dell'ascensione e pertanto
il materiale per allestirli dev'essere trasportato lungo un percorso
impervio, magari a quote elevate, dove diventa troppo faticoso
portare carichi molto pesanti.
Gli alpinisti spesso salgono e scendono più volte dai campi
intermedi, perché magari un giorno salgono, il giorno dopo
vogliono salire ancora ma il tempo è brutto, allora scendono
che a quote inferiori si sta meglio e il campo base è più
confortevole, poi risalgono quando ritorna bello per tentare la
cima i giorni successivi e così tutte le conquiste partono
da qui, da un campo base, un attendamento che guarda verso l'altezza
a cui volgono imprese imminenti.
Canto
Per canto si intende l'emissione di suoni musicali modulati dalla voce umana: questa, come uno strumento musicale, passa da una nota all’altra della scala dei suoni seguendo per lo più una misura ritmica e una o più tonalità. Più in particolare il canto è l’interpretazione vocale della musica. Il canto può essere melodioso, allegro, gioioso. Oppure può essere triste, sommesso, o di guerra. Ci sono vari tipi e stili di canto, come i canti della montagna, come gli jodel (o jodler); come il canto liturgico, il canto ambrosiano o quello gregoriano. A proposito di questi dobbiamo dire che Il canto è stata una delle prima espressioni musicali dell’ uomo e alle origini veniva praticato senza accompagnamento musicale, soprattutto in chiesa e nelle prime comunità cristiane, in quanto gli strumenti, usati per accompagnare le danze profane, erano ritenuti indegni dei luoghi di preghiera. Il canto gregoriano della chiesa romana è monodico, corale, diatonico e dotato di ritmo libero. Dal canto gregoriano differisce, per la maggiore ricchezza di accenti ritmici, il canto ambrosiano, ancor oggi praticato dalla chiesa milanese. Questi due canti eserciteranno per secoli un’influenza profonda anche sulla musica profana. Nella religione si parla anche del canto degli angeli, che è il modo di comunicare che gli angeli hanno con le creature della Terra. Ma per canto possiamo anche intendere il canto della natura, come il verso musicalmente modulato emesso dagli uccelli e da taluni animali: il canto dell'usignolo ; il canto delle rane , dei grilli. Ci sono anche dei modi di dire popolari, come: levarsi al canto del gallo, e cioè all'alba; oppure il canto del cigno, che indica, in senso traslato, l’ultima e la più alta opera o azione compiuta da qualcuno, specialmente da un artista; infatti, secondo la leggenda, il cigno prima di morire eleva il suo canto più melodioso. Il canto degli alberi, della foresta. Il canto del mare tra gli scogli. Ci sono anche dei proverbi che racchiudono il canto, come " Oggi in pianto, domani in canto", cioè a un dolore succede una gioia. In letteratura il canto è una poesia lirica. Inizialmente infatti la poesia era destinata al canto, accompagnato da strumenti musicali. Una delle forme più diffuse dell’antica lirica romanza è infatti la canzone. Cantare fa bene: si dice "Canta che ti passa!!!". Infatti alcuni esperimenti dimostrano come cantare aumenti "di più il benessere psicologico rispetto al semplice ascoltare musica. Le migliori canzoni devono essere semplici e ripetitive, come i canti popolari. Col passare del tempo e con la nascita della polifonia cambia il modo di cantare; non si ha più un coro (=gruppo di individui che cantano insieme) che esegue il canto in una singola tonalità (coro gregoriano), ma si usano più tonalità, fuse tra loro secondo le leggi dell’ armonia musicale. Le realtà corali hanno il loro ruolo sociale: sempre più spesso, infatti, l'istituzione di cori non viene promossa solo in ambiti didattici (conservatori, scuole e istituti musicali etc) e istituzionali (Università, corpi armati, etc) ma anche nel sociale (parrocchie, centri culutrali, di accoglienza, di aggregazione, etc) perchè il coro è risultato un efficace strumento per rafforzare i legami sociali e promuovere il coinvolgimento di gruppi socialmente svantaggiati come ad esempio anziani e senza tetto. I partecipanti a queste iniziative riportano nel tempo un aumento del benessere personale, del senso di appartenenza e sostegno sociale, di autoefficacia ed autostima . Studi hanno messo in luce che la partecipazione ad attività congiunte altamente sincronizzate, come quelle sportive e musicali, induce una maggior secrezione di endorfine rispetto alle stesse attività svolte individualmente, producendo non solo un maggiore senso di euforia personale ma anche un aumento della cooperatività e della coesione interpersonale. Sarà forse per questo che, storicamente e culturalmente, danze e canti in gruppo sono stati a lungo momenti integranti della vita sociale, come occasioni di aggregazione e partecipazione comunitaria. Partecipare ad un coro è il modo migliore per sviluppare una coscienza di gruppo, bisogna imparare ad adattarsi al ritmo degli altri e ad ascoltarsi reciprocamente. Il canto è utilizzato, possiamo dire universalmente, per esprimere delle forti emozioni, oppure per dichiarare un sentimento, o per pregare, o per farsi coraggio. In passato si intonavano delle melodie per alleviare la fatica, nei luoghi di lavoro, nei campi, per farsi coraggio nei momenti difficili e per comunicare con le divinità. Ricordiamo i canti di guerra o i canti propiziatori delle popolazioni più antiche. Sembra che, intonando una canzone che ci piace, si stimolano i neuroni a lavorare con un sincronismo 5 volte maggiore rispetto al normale. Anche questo meccanismo attiva la produzione di endorfine, i calmanti naturali, e fa in modo che ricordi, esperienze e immagini passate ritornino alla mente. È sufficiente intonare qualche frase di una canzone che ci ha accompagnato in momenti piacevoli o meno piacevoli della nostra vita per ricreare la scarica neurormonale, l'emozione, che aveva attraversato il corpo in quella situazione. Il canto, il cantare, quindi, libera le emozioni imprigionate e permette di scaricare l’energia intrappolata dentro di noi, alleviando ansia e paure. E questo lo possiamo vedere subito con la respirazione perché quando cantiamo i polmoni funzionano come una fisarmonica: si riempiono e si svuotano di aria appoggiandosi al diaframma, mentre con lo stress e le tensioni blocchiamo il respiro. Il canto è anche un mezzo per creare empatia, perché chi emette suoni gradevoli e/o sgradevoli trasmette anche agli altri le sue emozioni. Ogni suono grave, acuto, lento o veloce, tocca chi ascolta, entrando così in sintonia. Se poi si canta insieme la vicinanza aumenta. Il canto, infine, aiuta molto le persone ad entrare in contatto con sé stessi, dato che per cantare, bisogna entrare in contatto con il proprio corpo.
Cartografia
Tutto ciò che riguarda le carte geografiche, topografiche,
geologiche o similari. La cartografia è l'insieme di conoscenze
scientifiche, tecniche e artistiche finalizzate alla rappresentazione
simbolica ma veritiera di informazioni geografiche - o statistiche,
demografiche, economiche, politiche, culturali, ma comunque in
relazione al luogo geografico nel quale si realizzano - su supporti
piani (carte geografiche) o sferici (globi). Gli studi cartografici
e le relative applicazioni nei diversi campi applicativi sono
state rivoluzionate dallo sviluppo e dalla diffusione dei Sistemi
Informativi Geografici (GIS).
E’ importante conoscerla, perché può essere
assolutamente utile in momenti di difficoltà in territori
sconosciuti.
La cartografia/cartologia serve all’escursionista a progettare
un’escursione sulla carta.
Lo studio delle carte serve all’escursionista per orientarsi
all’interno dello spazio in cui si trova.
L’operazione più importante della cartografia è
l’orientamento delle carte, perché tutto quello che
su di esse è rappresentato sia allineato alle posizioni
e alla direzioni esistenti sul terreno circostante. Questo permette
un iniziale orientamento spazio-temporale (geografico), che va
“potenziato” con dei punti di riferimento posti sul
terreno. Si traccia un segmento sulla carta che unisca il punto
di riferimento (ben visibile ed identificabile) a noi, e si userà
il segmento come il mirino, puntando un’estremità
a noi e l’altra verso il riferimento scelto.
I gruppi principali della cartografia
sono:
sentieri
confini
presenza dell’acqua
zone boschive
tipi di vegetazione
l’orografia
INOLTRE:
linee ferroviarie
strade rotabili
ponti
SEGNI CONVENZIONALI IGM:
case / industrie / stazioni / miniere
centrali idroelettriche
chiese / cimiteri
aeroporti / porti
acquedotti
stazioni
canali
vegetazione
quote topografiche
punti geodetici
|
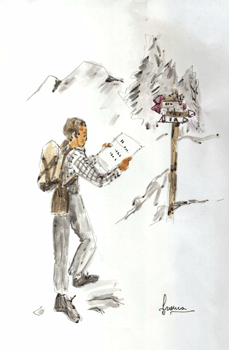 |
Cielo
Il cielo (dal latino coelum, di etimologia incerta) è
l'atmosfera della Terra vista dalla sua superficie. A causa della
rifrazione e diffusione della luce del sole nell'atmosfera, di
giorno il cielo appare di colore azzurro, con sfumature rosse
o gialle all'alba e al tramonto.
Il colore azzurro del cielo è più scuro in alta
montagna, a causa della minore densità dell'atmosfera.
Sulla Luna e nello spazio, dove l'atmosfera manca del tutto, il
cielo è perennemente nero e le stelle sono visibili anche
di giorno.
Talvolta nel cielo si osservano alcuni fenomeni, come:
• l'arcobaleno (ved. ARCOBALENO), costituito da
uno o due archi di cerchio colorati (arcobaleno primario e secondario)
che si osservano nel cielo quando vi è una nuvola di goccioline
d'acqua in sospensione, tipicamente dopo un temporale. Ciascun
cerchio è costituito da bande di diversi colori: tradizionalmente
si identificano sette colori.
• l'aurora boreale è una luminescenza colorata,
molto spettacolare, causata dall'interazione tra il vento solare
e il campo magnetico terrestre. Solitamente si osserva nelle regioni
artiche e antartiche, vicino ai poli magnetici, ma talvolta si
verificano aurore eccezionali visibili anche a latitudini più
basse.
• il raggio verde si osserva talvolta per pochi
secondi al tramonto: per poterlo vedere occorrono particolari
condizioni atmosferiche e osservative.
PERCHÉ IL CIELO È BLU?
Nell'attraversare l'atmosfera, la maggior parte della radiazione
di maggior lunghezza d'onda (come quelle del rosso e del giallo)
prosegue la sua traiettoria rettilinea. La luce rossa, arancione
e gialla,infatti, viene influenzata solo in minima parte dalla
presenza dell'aria. Al contrario, la luce blu, di minore lunghezza
d’onda, è diffusa in tutte le direzioni: in qualunque
direzione si osservi, parte di questa luce giunge ai nostri occhi.
Il cielo, pertanto, appare blu.
Fin dai primi tempi dell'umanità il Cielo è stato
oggetto di osservazione e di studio da parte degli uomini. Il
cielo si osservava per motivi economici (lavoro, agricoltura)
e per motivi religiosi. E spesso questi motivi erano coincidenti.
Ben presto si osservò che nel cielo notturno le stelle
si spostavano seguendo un ciclo regolare e mantenevano sempre
la stessa posizione relativa. I gruppi di stelle otticamente vicine
tra loro vennero chiamati costellazioni e identificati col nome
di animali reali (es. il Leone) o di fantasia (es. l'Idra) o di
personaggi mitologici (es. Orione).
Lo studio del cielo è legato anche all'evolversi dell'arte
della navigazione perché la conoscenza delle posizioni
degli astri nel cielo permetteva al navigante di orientarsi e
così seguire la rotta giusta.
La parola greca che indica il cielo è ouranos,
quella latina coelum, dall’etimologia ignota. In
molte lingue antiche e moderne la parola ha due significati. In
inglese sky è il cielo in senso scientifico oggettivo,
mentre heaven è il cielo in senso religioso. In
ebraico i samayim - i cieli al plurale - hanno un riferimento
religioso, mentre raqia è il firmamento. Fino
dall’antichità quindi il cielo era il luogo della
trascendenza, la dimora spirituale di Dio. Vasto e sconfinato,
dava l’idea dell’immensità di spazio, dell’universalità
di pensiero, della pienezza del sentimento, della dolcezza e della
grazia, e della beatitudine.
Il cielo può essere anche nel profondo. Il latino
altus significa sia alto che profondo.
La povertà - diceva S. Francesco - è quella
virtù la quale fa l’anima, ancor posta in terra,
conversare in cielo con gli Agnoli. Questa è quella ch’accompagnò
Cristo in sulla Croce; con Cristo fu soppellita, con Cristo resuscitò,
con Cristo salì in cielo ... e in questa vita concede all’anime
che di lei innamorano, agevolezza di volare in cielo (XIII).
Collaborazione
Ovvero l'interazione tra persone. Il lavorare insieme; il contribuire, insieme ad altri, alla realizzazione di un progetto, il partecipare ad un’attività comune. Aiutare gli altri per il raggiungimento di una meta.
Condivisione
Spirito di fiducia, cooperazione e dono di sé, che costituisce
il motore della vita di relazione e che può portare all'avvio
di nuove esperienze di vita comunitaria. Porta ad abbandonare
il vecchio modello di relazione basato sulla competitività
e sulla lotta per acquisire posizioni di preminenza.
Ci aiuta a re-imparare assieme a prendere decisioni partecipate
e consensuali; ad ascoltare gli altri; a collaborare, seguendo
anche i sensi, l'intuito e non solo la ragione; ad esplicitare
esigenze, desideri, aspettative; convivere apprezzando le differenze
che ci sono fra noi; a rispettare il diritto di ognuno di essere
come è; ad accettare la storia di ognuno senza giudizi,
o senza pregiudizi.
La comunicazione della condivisione è la chiave dell'auto
mutuo aiuto.
Condivisione è: l’avere qualcosa, un’idea,
un progetto, in comune con altri, e dividere con gli altri quello
che si possiede, anche a livello emotivo.
Condividere un pezzo di pane, condividere un progetto, condividere
un rifugio, condividere una speranza, condividere il freddo, condividere
un momenti di felicità, condividere una situazione brutta….
Quante volte in montagna ci siamo trovati a condividere. Condividere
è ciò che crea il gruppo.
Contaminazione
La contaminazione è l'incontro paritario tra due o più
culture al tavolo della creatività, un incontro nel rispetto
delle tradizioni di ogni cultura, il cui risultato è il
frutto dell'accettazione reciproca. Essa può agire in almeno
tre dimensioni: quella artistica, quella storica e quella spaziale.
Nella dimensione artistica (ed espressiva) la contaminazione prevede
un dialogo creativo tra diverse forme artistiche. Nella dimensione
storica la contaminazione si fonda sulle stratificazioni di generi
susseguitesi nel tempo (stratificazione diacronica). Nella dimensione
spaziale la contaminazione agisce coniugando materiale proveniente
da tradizioni di diverse, regioni culturali. Le tre dimensioni
della contaminazione non sono compartimenti stagni, ma elementi
che frequentemente interagiscono tra di loro; ciò da vita
ad una continua tensione globale-locale, in cui le forme e i contenuti
regionali si riversano, e si trasformano, nel globale; così
come le forme e i contenuti globali si riversano, e si trasformano,
nelle realtà regionali.
La contaminazione, quindi, è la fusione di più elementi
che provengono da diverse parti, un incrocio di “cose”
diverse che può dare origine a “cose” nuove.
Contemplazione
L’escursionismo e l’alpinismo come occasione di contemplazione sono una possibilità nota al popolo dei frequentatori della montagna.
Nel corso di una delle periodiche uscite collettive, cui partecipano più gruppi di attività del Lazio, con qualche esitazione – date le condizioni atmosferiche non favorevoli - una trentina di persone partono dal Convento francescano di San Giacomo a Poggio Bustone e prendono a salire lungo il sentiero che conduce, con numerosi tornanti, al Sacro Speco, la grotta dove San Francesco si ritirava in preghiera e dove – si racconta – ebbe la rivelazione che l’Ordine da lui fondato si sarebbe sviluppato e diffuso.
|
|
Siamo a dicembre, la giornata è grigia, fredda e piovosa. Mano a mano che saliamo la pioggia diventa neve. Giunti al Sacro Speco siamo completamente avvolti dalla nevicata; grossi fiocchi scendono lenti nell’aria ferma.
Qualcuno propone di restare in silenzio; ma è la nevicata stessa, con la sua atmosfera ovattata, che suggerisce il silenzio; subito ogni voce si ferma.
Restiamo così, in una condizione sospesa che sembra fuori dal tempo, lontani dai suoni e rumori della vita di ogni giorno che scorre laggiù, in fondo alla pianura, senza di noi. Possiamo ascoltare il ritmo del respiro e del cuore, sollecitati dalla salita appena compiuta; immersi nel leggero fruscio della neve che si posa. |
Coro
Insieme di più voci emesse contemporaneamente. Una pratica
esecutiva comune a tutte le civiltà, dai tempi più
remoti, cosicché la sua storia e le sue forme coincidono
in gran parte con quelle della musica stessa in generale. Si chiama
monodico se le voci intonano la stessa melodia; polifonico quando
le voci cantano melodie differenti, a volte anche con ritmi diversi.
Specie nella musica popolare il coro può rispondere a una
funzione sociale, come pratica che integra, accompagna o celebra
momenti di carattere religioso o civile, della vita di una comunità.
O può essere semplicemente un modo di intrattenimento collettivo
o di partecipazione del gruppo ai fatti importanti della vita
di una persona. Può esprimere sentimenti individuali, ma
è spesso espressione di sentimenti collettivi, come quando
fa da commento ad un’azione epica. Talvolta dà voce
ad una moltitudine. Nel melodramma, ad esempio, il coro rappresenta
di solito certe comunità o categorie di persone. In altre
forme musicali, il coro non svolge un ruolo scenico, ma viene
utilizzato per i suoi valori musicali e costruttivi. (Enciclopedia
della musica, Garzanti, 1996)
Il coro affonda le sue origini nel passato: si attribuisce l’invenzione
di questa pratica agli antichi greci, i quali la utilizzavano
nel teatro, durante lo svolgimento delle tragedie, come voce narrante
esterna alle scene.
In montagna, durante i trasferimenti in macchina o in pulmino,
nella natura, al rifugio, camminando o alla fine di un pasto consumato
insieme, il coro è una possibilità artistica e creativa
di stare insieme. E’ una forma di espressione intima di
ciascuno, nell’ascolto attento dell’altro. E’
un modo semplice di “fare gruppo”, un’esperienza
di condivisione. Cantare in coro unisce, diverte, rilassa, spesso
emoziona. Intonati e mezze campane, soprani lirici e fumatori
rauchi, tutti danno il proprio contributo, sostenendosi, compensandosi,
con un risultato finale, che, comunque vada, è sempre qualcosa
in più della somma delle voci dei singoli.
Crepaccio
Un crepaccio è un'alterazione geomorfologica della superficie di un suolo, di una roccia o di un ghiacciaio; con il termine si indica in genere una spaccatura profonda e di grandi dimensioni. Si forma per effetto di uno squilibrio tra forze di natura contrastanti quali ad esempio lo scivolamento per gravità che supera localmente la forza di coesione del ghiaccio. In questo caso, ad esempio, la massa glaciale, nel suo movimento verso valle, determina delle grosse tensioni in profondità parallele al flusso del ghiaccio: queste tensioni differenziali (di pressione o di distensione), a seconda soprattutto della conformazione del terreno e della diversa velocità di scorrimento, trovano sfogo in superficie formando le fenditure dei crepacci, che possono essere profonde a volte fino a 50 m e larghe qualche metro. Un altro modo in cui si può formare un crepaccio è dovuto alle tensioni di taglio provocate dal contatto della colata di ghiaccio con le pareti rocciose laterali. Rispetto alla tipologia dei ghiacciai, questi si possono classificare in base a diversi parametri: Posizione: crepacciate terminali; crepacci marginali o periferici (formati da una parete di ghiaccio e una di roccia); crepacci centrali; crepacci frontali. Disposizione: trasversali (si formano trasversalmente alla colata di ghiaccio, arcuati e concavi verso valle); longitudinali (si formano in direzione della colata a seconda del suo restringimento/allargamento); obliqui (si formano ai lati a contatto con la roccia). A seconda della conformazione del letto glaciale, si avranno crepacci di due diversi tipi: "crepacci a Y" (larghi in superficie e gradualmente stretti verso il fondo a causa della porzione di suolo sottostante convessa); "crepacci a campana" (al contrario dei precedenti, sono stretti in superficie e si allargano man mano verso il fondo a causa della porzione di suolo sottostante concavo). I crepacci costituiscono un rischio reale nella pratica dell'escursionismo, dell'alpinismo d'alta quota e dello sci alpinismo su ghiacciaio per la possibile caduta della persona all'interno di esso, specie se nascosto da uno strato sottile di neve (detto "ponte di neve"). Per evitare ciò, oltre alla conoscenza dettagliata della morfologia del ghiacciaio da parte delle guide alpine e degli escursionisti, la tecnica che abitualmente si usa è l'attraversamento in cordata del ghiacciaio in modo tale che un eventuale caduta del singolo possa essere arrestata dal peso/inerzia degli altri escursionisti
|
|
 |
|
 |